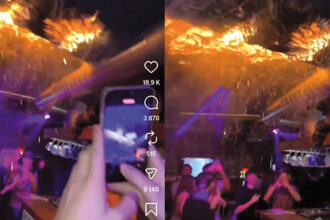Alla scoperta di un libro
Prendiamo un classico, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). E mettiamo un momento da parte il drammaturgo e il gran narratore dei romanzi più noti, come Il giudice e il suo boia (1950), La panne (1956) o La valle del caos (1989), quello sottilmente giallista, indagatore degli abissi umani più che delle alte quote da voli pindarici dell’intelletto, ma sempre teso alla riflessione sociologica, quello de Il sospetto (1951), La promessa (1957) o L’incarico (1986), quello dei tanti racconti, romanzi brevi e pamphlet (tutte opere da riscoprire, rileggere, cercare), e dedichiamo qualche minuto di rispettosa attenzione a questo libretto, 68 pagine in tutto, prodigo di stimoli letterari, filosofici, emotivi. E perfino laicamente teologici, o teologicamente laici, se preferite.
La morte della Pizia (Das Sterben der Pythia) è un racconto tratto dal Mitmacher, una variegata raccolta di varie opere per così dire “minori” (racconti brevi, riflessioni, appunti di drammaturgia e di vita), del 1976, pubblicato come volumetto singolo nel 1985 dalla Diogenes Verlag di Zurigo, e tradotto in italiano nel 1988 per i tipi della Adelphi di Milano, nella collana Piccola Biblioteca Adelphi, vol. 216 (ormai giunto alla 33ª edizione), nella valente traduzione di Renata Colorni.
Siamo in ambito mitologico. Grecia antica, santuario di Delfi. E la Pizia con cui Dürrenmatt ci intriga è l’ennesimo oracolo che di generazione in generazione si succedette sul noto tripode posto in una rupe a cavernetta davanti al Tempio di Apollo nella famosa località storica, ancor oggi visitabile nella sua suggestiva veste di prezioso sito archeologico.
Ma non si tratta di un’apologia dei miti antichi né un elogio storicista del buon tempo che fu millenni fa, fascinosamente ammantato di incanto e mistero. Tutt’altro. Dürrenmatt stabilisce fin da subito un registro beffardo e insolente da dissacratore spietato par suo. Eccone l’incipit.
«Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l’ingenua credulità dei Greci, la sacerdotessa di Delfi Pannychis XI, lunga e secca come quasi tutte le Pizie che l’avevano preceduta, ascoltò le domande del giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori, come se fosse facile stabilire una cosa del genere nei circoli aristocratici, dove, senza scherzi, donne maritate davano a intendere ai loro consorti, i quali peraltro finivano per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse giaciuto con loro».
Un solo paragrafo, il primo oltretutto, lunghetto ma scritto magistralmente, e di magnifica scorrevolezza, nel quale l’autore ci cala subito nell’irrisoria realtà ridimensionante di una figura, e di un intero mito, sfatati nella realtà dei fatti. Magari anche solo filosoficamente ipotizzati, e immaginati.
Proseguendo nella lettura, la Pizia, stanca a fine giornata e infastidita dall’atteggiamento del giovane claudicante che viene a farsi vaticinare il futuro, un futuro che lei – per quanto possa sembrare incredibile – crede fermamente impossibile da prevedere, si diletta malignamente lì per lì a fare…
«(…) una profezia che più insensata e inverosimile non avrebbe potuto essere, la quale, pensò, non si sarebbe certamente mai avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio padre e andare a letto con la propria madre, senza contare che per lei tutte quelle storie di accoppiamenti incestuosi fra dèi e semidei altro non erano che insulse leggende».
È un capovolgimento totale di prospettiva che l’autore chiede, immediatamente, al lettore, con un espediente narrativo pari a un ceffone in faccia.
La complessa vicenda mitologica di Edipo si dipana così sotto i nostri occhi, prefigurata per sommi capi introduttivi dallo stesso protagonista e dettagliata poco dopo da Giocasta, la madre incestuosa, che la ascrive con rassegnato fatalismo a un non meglio precisato decreto degli dèi, alla quale Pannychis XI ribatte senza mezzi termini:
«Carogna» gridò la Pizia con voce roca «sei proprio una carogna a parlare di decreto degli dèi quando sai benissimo che quell’oracolo è tutto un imbroglio inventato da me di sana pianta!»
Vi basta? È abbastanza spiazzante? Ma non finisce qui. Alla Pizia a questo punto compare un’ombra che prende le sembianze di Tiresia, il famoso veggente cieco, che le spiega…
«Pannychis,» continuò Tiresia in tono conciliante «anch’io come te sono una persona sensata, come te non ho fede negli dèi e credo invece nella ragione, e proprio perché credo nella ragione sono persuaso che l’insensata fede negli dèi debba essere sfruttata in maniera ragionevole (…).»
La razionalità, dunque, è guida suprema per Dürrenmatt, anche a costo di negare la mitologia, senz’altro, e perfino la storia, forse, benché solo temporaneamente. Forse.
Ed emerge anche il pessimismo dürrenmattiano circa la propensione generale degli esseri umani a essere estremamente pratici, quando è il caso, opportunisti, spesso, e arrogantemente incompetenti, sempre più sovente. Specie in campo politico, verrebbe da dire. Poiché Friedrich Dürrenmatt è autore polemico, urticante, cinico, ma gran maestro dell’ironia e dei colpi di scena più sarcastici, sebbene amari.
Segue una discussione straordinariamente interessante tra la Pizia e Tiresia, alla quale il lettore più attento si può approcciare come a un lauto banchetto non già di banali leccornie materiali bensì di pregnanti riflessioni esistenziali. E Tiresia a un tratto dice:
«Perché mai, Pannychis, la gente dice sempre verità approssimative, come se la verità non risiedesse soprattutto nei singoli dettagli? Forse perché gli uomini stessi sono soltanto qualcosa di approssimativo. Maledetta imprecisione. (…).»
E qui Dürrenmatt rivela il suo innato senso civico genuinamente elvetico. L’ordine, il dettaglio, la precisione. A servizio della verità, musa ispiratrice e bussola morale dell’autore, che la cerca e persegue spesso nei suoi racconti e romanzi in cui ignoti commissari di polizia o stanchi giudici fatalisti si cimentano nell’affannosa ricerca di un colpevole, spinti da un profondo senso di giustizia, ma altresì da un’interiore aspirazione esistenziale non disgiunta da una profonda, autentica, etica sociale, imparziale e libera da qualsiasi vincolo.
Dopo ulteriori riflessioni e scambi tra l’indovina e il veggente, la Pizia, tra le altre cose, asserisce:
«(…) Tutti i tiranni che fondano il loro dominio su grandi princìpi, l’uguaglianza dei cittadini tra loro o l’idea che i beni di ognuno appartengano a tutti, suscitano in coloro sui quali esercitano la loro potestà un sentimento di soggezione incomparabilmente più mortificante di quelli che, anche se assai più ignobili, si accontentano come Laio di fare i tiranni, troppo pigri per addurre una qualsiasi giustificazione al proprio comportamento: essendo la loro dittatura lunatica e capricciosa, i sudditi hanno la sensazione di poter godere di una certa libertà. Non si sentono tiranneggiati da una arbitraria necessità che non consente loro speranza alcuna, ma piuttosto da un arbitrio assolutamente casuale che ancora permette qualche speranza».
Ecco l’autore polemista e anticonformista. E quanto sono attuali le sue considerazioni “politicamente corrette”!
Ma per chi ama soprattutto il bello scrivere non mancano di certo gli spunti descrittivi e poetici. Eccone un esempio, dopo tanto discettare. Si è fatto mattino e i due vaticinatori si avviano alla scomparsa, l’uno, e all’annunciata morte, anch’essa per graduale sparizione, l’altra.
«La notte aveva ceduto il posto ad un plumbeo mattino, che di colpo aveva fatto irruzione nella caverna oracolare. Eppure, ciò che irresistibilmente stava dilagando non era mattino e non era notte, bensì qualcos’altro, qualcosa di irreale, né luce né buio, senz’ombra, senza colore. Come sempre nelle prime ore dell’alba, i vapori depositandosi sul pavimento di pietra, creavano uno strato di fredda umidità e, appiccicandosi alle pareti, formavano gocce nere che per il peso colavano piano piano e sparivano nella fessura della terra sotto forma di lunghi e sottili filamenti».
Sembra di esser presenti; si avverte il freddo e si prova la medesima contrarietà della Pizia e di Tiresia.
Si è ormai giunti alle conclusioni, ma con caparbia per quanto stremata razionalità i due ancora non rinunciano né al dubbio né all’irrisione, né a tentare di far luce sulla verità.
«Una cosa soltanto non riesco a capire» disse la Pizia. «Che il mio oracolo si sia avverato, anche se non come Edipo se l’immagina, è frutto di una incredibile coincidenza; ma se Edipo ha creduto all’oracolo fin da principio e se la prima persona che ha ucciso è stato l’auriga Polifonte e la prima donna che ha amato è stata la Sfinge, se questo è vero, come mai non gli è venuto il sospetto che suo padre fosse l’auriga e sua madre la Sfinge?».
«Perché Edipo preferiva esser il figlio di un re piuttosto che il figlio di un auriga. Il suo destino se lo è scelto da sé» fu la risposta di Tiresia.
«Noi e il nostro oracolo,» sospirò amareggiata la Pizia «solo grazie alla Sfinge siamo venuti a conoscenza della verità».
«Non saprei,» fece Tiresia pensieroso «la Sfinge è una sacerdotessa di Hermes, il dio dei ladri e degli impostori».
Fino all’ultimo Dürrenmatt proclama il suo, e il nostro, diritto a essere liberi pensatori, affrancati perfino dall’idea del soprannaturale, oltre che dai miti. È Tiresia a delineare la sofferta conclusione, quando afferma:
«Dimentica le vecchie storie, Pannychis, non hanno alcuna importanza, in questa grande babilonia siamo noi i veri protagonisti. Noi due ci siamo trovati di fronte alla stessa mostruosa realtà, la quale è impenetrabile non meno dell’essere umano che ne è l’artefice. Forse gli dèi, ammesso che esistano, potrebbero godere dall’alto di una certa visione d’insieme, sia pure superficiale, di questo nodo immane di accadimenti inverosimili che danno luogo, nelle loro intricatissime connessioni, alle coincidenze più scellerate, mentre noi mortali che ci troviamo nel mezzo di un simile tremendo scompiglio brancoliamo disperatamente nel buio. (…)».
E solo nelle ultime due pagine l’autore svela il suo pensiero, non più quello della Pizia di Delfi o di Tiresia di Tebe, o di Edipo o della Sfinge. Ossia che la ragione cerca sempre di fare ordine negli avvenimenti, anche i più paradossali, della vita, ma si deve arrendere spesso alla casualità di un mondo in cui regna il caos. Nonostante con l’immaginazione taluni si sforzino di giustificare il caso o prefigurino un destino o uno scopo con inguaribile utopismo, mentre altri si accontentino di un pacato, irrimediabile pessimismo.
Fabrizio Pezzoli

La Gazzetta ha bisogno di te.
Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.