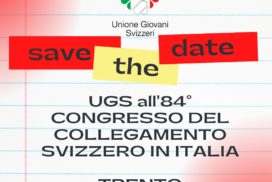Giornalista, reporter di guerra e autore di Vite al fronte
«Raccontare la guerra significa attraversarla, viverla in prima persona, cercare di restituire la realtà senza filtri, senza compromessi. Per molti, la guerra è un titolo di giornale, un’immagine fugace che scorre sullo schermo. Per chi la racconta, invece, è un'esperienza che segna, che cambia lo sguardo sul mondo e il modo di vedere la vita.»
Oggi incontriamo Luca Steinmann, un giovane reporter italo-svizzero che ha scelto di essere in prima linea, di dare voce a chi spesso non ne ha, di raccontare le storie che altrimenti resterebbero sommerse dal rumore delle armi.
Un impegno che ha recentemente trasformato in parole con il suo libro “Vite al fronte”, in cui raccoglie le sue esperienze dirette nelle diverse aeree di conflitto. Con lui parleremo del suo lavoro sul campo, delle sfide di questa professione e di come il giornalismo possa ancora fare la differenza in un mondo sempre più complesso.
- Ciao Luca, cosa ti ha spinto a diventare reporter di guerra? E in quali scenari sei stato?
«Ho iniziato circa una decina di anni fa in cui mi interessavo dell’attualità in Italia, in Svizzera e in Europa, vedevo i grandi temi che venivano dibattuti come l’immigrazione e il terrorismo e mi dicevo che per poter raccontare e conoscere questi fenomeni bisognava andare là dove questi hanno origine o pensiamo abbiano origine, quindi in questo caso, nella regione Medio Orientale.
Sono partito per la prima volta e sono andato in Libano, da dove ho iniziato vendere i miei primi articoli e video.
Poi sono ritornato in Libano e ho viaggiato in altri Paesi e da lì a poco a poco è diventato il lavoro che faccio oggi.
Non è un lavoro che segue uno schema specifico, ma è molto spontaneo e artigianale.
Negli ultimi anni ho seguito principalmente tre grosse aeree di crisi: la regione russo – ucraina, il Medio Oriente (crisi siriana, crisi dei rifugiati in Giordania, guerra in Libano, Israele e Palestina ecc…) e il Caucaso (Guerra tra Armenia e Azerbaigian).
Inoltre, ho realizzato reportage nel Kosovo, in Cina, in Turchia e in altri Paesi europei.»
- Cosa distingue un buon reportage di guerra da un “semplice” resoconto di eventi?
«Penso che il principio sia lo stesso, fare reportage significa andare sul territorio e raccontare la complessità di quel territorio partendo dal lugo in cui ti trovi, non solo attraverso conoscenze astratte, ma combinando le conoscenze storiche di un Paese o di un fenomeno con l’esperienza sul campo, il confronto con le persone.
Non c’è un momento preciso in cui si possa dire da qui inizia ufficialmente la guerra, mentre in là non c’è.
Si tratta di un processo più graduale, ci sono aeree di crisi dove, a causa delle guerre, arriva la gente che scappa dai combattimenti, che sono lì a causa della guerra.
Ci sono i grandi problemi umanitari legati ai conflitti che si possono raccontare, le grandi migrazioni e da qui io a poco a poco mi sono avvicinato sempre di più al campo di battaglia.
Non ho mai avuto un momento che ho definito il mio battesimo col fuoco, il mio primo reportage di guerra, anche perché io sono un giornalista che si occupa di esteri e non solo di guerra. Le guerre purtroppo hanno un ruolo di primo piano nelle nostre relazioni internazionali e di conseguenza sono capitato anche lì.»
- Hai lavorato in territori contesi tra grandi potenze, dove la narrativa cambia a seconda di chi racconta la propria versione della guerra. Qual è stato il caso più eclatante di manipolazione della verità che hai vissuto in prima persona?
«Non ho solo un caso maestro, in quanto la questione è più sfumata.
Oggi con le tecnologie che abbiamo a disposizione, i social, l’immediatezza dell’informazione, qualche secondo dopo che un evento succede è già su tutti gli smartphone del mondo, è più difficile creare delle trappole comunicative, delle cosiddette false flag, in cui inscenare qualcosa che non sia mai realmente esistito.
Penso che le diverse narrazioni, le diverse propagande che ci sono si fondino più che altro su tanti episodi, uno dietro l'altro, falsi o fuorvianti, che vengono raccontati, messi all'interno di una narrazione che poi porta a descrivere il mondo in modo propagandistico e bisogna fare attenzione al fatto che questi episodi possano essere delle menzogne, ma possono anche essere cose vere, dicendo soltanto alcune cose vere e tralasciandone delle altre si può raccontare una cosa.
Ad esempio, il caso più classico è dire c’è l’esercito X che bombarda la popolazione civile di una città.
Noi assumiamo che sia una cosa assolutamente vera, ma bisogna verificare: ci sono anche dei soldati che da quella città bombardano verso esercito X?
In quel caso la situazione cambia, non è più un bombardamento gratuito su una popolazione, ma è una guerra in cui la popolazione si trova in mezzo o addirittura viene utilizzata come scudo umano.
Questo dibattito l’ho ritrovato in tutte le guerre in cui sono stato, nella guerra in Ucraina, nel Donbass, anche naturalmente per tutto quello che riguarda la Striscia di Gaza.
Non ho un episodio da citare che sia maestro di disinformazione, perché oggi questi episodi troppo grossi sono facilmente verificabili. Tutti hanno uno smartphone, tutti possono vedere, tutti possono fare circolare le proprie informazioni, ma è più una questione di dichiarazione di narrazioni propagandistiche fondate su frame fuorvianti.»
- Essere fermato e affrontare processi in territori occupati è una realtà che pochi giornalisti raccontano apertamente, cosa, invece che tu hai fatto nel tuo ultimo libro. Hai mai avuto paura che un fermo potesse trasformarsi in una condanna definitiva? E quanto queste esperienze hanno influenzato il tuo modo di fare reportage?
«Io ho avuto la fortuna di non essere mai stato veramente maltrattato. Ho subito magari delle prepotenze, ma mai delle violenze. Certamente, il problema diventa di tipo professionale, in quanto se uno stato di fermo o uno ostracismo da parte di qualcuno ti impedisce di fare il tuo lavoro, ti impedisce di raccogliere informazioni o di pubblicare il tuo operato diventa una fonte di lavoro in meno per il giornalista.
In questo libro, in tutti quelli che ho scritto e come in tutto il mio lavoro cerco di non mettermi troppo al centro perché penso che sia poco rispettoso nei confronti delle persone che incontro e credo sia importante dar voce alle persone e come le dinamiche locali si sviluppino.
Però in alcuni casi, come ad esempio l’inizio del mio libro “Vite al fronte”, vengo trasformato in un protagonista, mio malgrado e ho deciso di raccontare questi episodi, come anche la volta in cui mi sono trovato a dover lasciare sia la Siria che il Libano nell'arco di un giorno proprio per far comprendere come sia complesso e complicato lavorare in certi territori e dover gestire tutta una serie di relazioni spigolose.
Lo scrivere, il girare, o anche l'incontrare certi tipi di persone risulta essere nella maggior parte dei casi una parte davvero minima della quotidianità lavorativa.
Infatti, gran parte del lavoro lo si passa a preparare documenti, a tessere relazioni, a conquistare la fiducia delle persone.
Si tratta di una piccola diplomazia quotidiana che occorre fare e penso che insegni anche molto e faccia vedere certi aspetti delle società e dei regimi con cui ho avuto modo di entrare in contatto e che altrimenti non avrebbero luce.»
- Nel tuo ultimo libro “Vite al fronte”, hai raccontato guerre molto diverse tra loro. Quali dinamiche comuni hai osservato tra questi conflitti?
«Innanzitutto, la voglia delle popolazioni di vivere in pace e di molte di queste di continuare a vivere lì dove appartengono e dove hanno casa, che è un’attitudine alla vita che magari da noi in Europa si è un po’ persa.
Nel momento in cui si viene forzati ad andarsene e si rischia di perdere tutto ciò che si ha, si sviluppa un senso d’attaccamento di patria fortissimo e genuino.
Da parte di molte delle persone un basso livello di ideologia. Le ideologie ci sono, così come i simboli, però poi scavando sotto, conoscendo le persone, ti rendi veramente conto che il senso di appartenenza che hanno è spesso qualcosa di molto meno politico e più umano e naturale.
Inoltre, il concetto di memoria è fortissimo, come le memorie di quello che è successo ieri vengano ereditate e tramandate dalle generazioni successive e su queste oggi si fondino le identità degli individui, delle famiglie, delle comunità e dei popoli.
Si creano così sensi di comunità strettissimi, pensiamo che cosa rappresenta la memoria dell'Olocausto per gli ebrei, la memoria della Nakba per i palestinesi, la memoria del genocidio per gli armeni.
Al contempo è proprio anche su queste memorie che germoglia l'odio per coloro o per i discendenti di coloro che hanno perpetrato le sofferenze del proprio popolo, dei propri genitori, dei propri nonni e dei propri bisnonni.
Il concetto di memoria funge da spartiacque tra amore e odio, dove da una parte lega una comunità in maniera profonda e dall’altra genera avversione.»
- Nel libro hai raccontato le storie di coloro che ti hanno fatto da guida nelle tue missioni, ma anche di civili locali che hai incontrato, come Bogdan, Rami e Taima. Quale di questi incontri ti ha colpito di più e perché?
«Non ho un personaggio preferito o che considero maggiormente sfortunato rispetto agli altri.
Penso che quello che mi colpisce in tutti, o perlomeno in tanti è questa forza nel reinventarsi.
Spesso a volte mi viene chiesto: “come fanno queste persone o continuare a vivere? Ma come si vive in guerra?” E io dico, si vive in maniera assolutamente terribile, ma anche con una normalità molto semplice e molto poco eroica. Nel momento in cui tu vivi in una situazione di guerra, di conflitto e questo conflitto perdura, dopo un po’ la vita va avanti. I bambini crescono, diventano adolescenti, e devono fare le loro esperienze, gli adolescenti diventano adulti devono se vogliono mettere su famiglia.
In tutti è presente questa ricerca di una normale quotidianità in una situazione che di normale non ha nulla e che si traduce nell'essere una grandissima forza.»
- Tra le varie figure, hai dedicato un capitolo a Mons. Hanna Jallouf, un religioso che con coraggio e forza d’animo si è posto come mediatore tra la sua comunità e le forze occupanti. Qual è, secondo te, il ruolo dei religiosi e delle religiose in contesti così complessi e drammatici?
«È un ruolo spesso fortissimo per più motivi. Come prima cosa, bisogna pensare che nel momento in cui si assume la consapevolezza che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, molte persone sviluppano caratteristiche umane terribili, ma tante altre assumono caratteri di una spiritualità profonda, in cui quindi la guida spirituale diventa una figura importantissima.
Spesso non si tratta di persone che si occupano soltanto di accudire spiritualmente i propri fedeli, ma che vanno ad assumere concretamente dei ruoli di capi comunità proprio alla luce della fiducia di cui godono tra i propri discepoli e quindi figure che negoziano, parlano direttamente con il potere, che incarnano loro stessi il potere.
Spesso, una loro fuga o dipartita comporterebbe la fuga e la fine della comunità che rappresentano.
Queste figure hanno la responsabilità di rimanere per far sì che la loro comunità non si sciolga.»
- Quanto è difficile tornare alla vita normale dopo una missione sul campo? La percezione dei problemi della nostra quotidianità dopo aver vissuto determinate situazioni muta?
«Forse cambia col tempo, ma comunque si rimane persone normali.
Ci sono periodi in cui di viaggi come questi ne si fa uno al mese oppure periodi in cui si viaggia di meno.
Quando si torna a casa si è assorbiti da tante cose da fare, azioni banali ma che sono comunque molto importanti. Intraprendere viaggi di questo tipo ti porta a fuggire da certi tipi di responsabilità.
Il rischio maggiore non è quello di vedere la vita in maniera più profonda, secondo me, ma di utilizzare questo lavoro come strumento di fuga da responsabilità della vita quotidiana.»
- Che consigli ti sentiresti di dare a un giovane che vorrebbe diventare giornalista di guerra?
«Fare il giornalista in Italia, ma non soltanto, è diventato molto più difficile perché gli editori sono in crisi e di conseguenza anche il settore lo è.
Può essere una bellissima passione il cui rischio di trasformarla in professione è sempre più complesso.
Personalmente avevo già l'idea di voler fare il giornalista e quando dovetti scegliere l’università la mia domanda era fare scienze delle comunicazioni o scienze politiche? Ossia studiare come comunicare nella mia banalità dovuta all’età di allora oppure studiare quello che avrei voluto comunicare?
Secondo una mia interpretazione personale, consiglio di studiare il più possibile la storia, le lingue e i contesti di cui ci si vorrebbe occupare.
E poi bisogna un po’ buttarsi. Non c'è un percorso di inserimento in questo lavoro che sia definito sicuro. Bisogna accettare una buona dose di rischio non soltanto fisico ma anche professionale, accettare una carriera sul filo del rasoio, non soltanto nei campi di battaglia, ma anche nel lavoro, proprio nella relazione coi datori di lavoro.
Infine, penso che quello che faccia la differenza sia che ciò che stai facendo ti piaccia davvero, io ad esempio, nel tempo libero farei quello che faccio di lavoro.»
- Oriana Fallaci scrisse «che nulla quanto la guerra, e ancor più una guerra ingiusta, frantuma la dignità dell’uomo». Nel tuo percorso da reporter, hai mai visto un uomo perdere la dignità e poi ritrovarla? Esiste un momento, un volto, una storia che ti ha fatto dubitare, anche solo per un istante, che la dignità potesse sopravvivere alla guerra?
«Non la ricollegherei ad un volto, perché io non ho mai visto i cattivi in quanto tali, il cattivo che ti ruba la borsetta all’anziana signora o spara ai gattini per strada.
La psicologia umana è molto più complessa, ho visto persone accusate dei crimini più efferati essere degli straordinari padri di famiglia o avere dei modi di fare accoglienti e gentili.
Credo soprattutto che il fatto di essere fortemente sotto pressione e vivere una guerra, in una società fortemente polarizzata possa facilitare l’emergere del peggio delle persone, ma anche del meglio.
Per questo motivo, in guerra si trovano spesso le cattiverie più gratuite e disumane e al contempo la spontaneità, la gentilezza e la dolcezza da parte di persone dalle quali non te lo aspetteresti.»
Nicola Magni

Sono ad Aleppo insieme al vescovo Armeno MagarAshkarian (2024)

Sono di fronte al Monastero serbo di Peć, in Kosovo (2024)
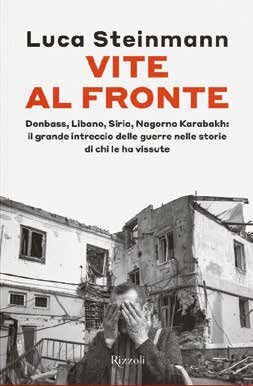

Sono nel Donbass con i soldati russi

La Gazzetta ha bisogno di te.
Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.