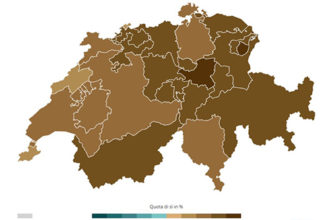Senior Product (non volatile memories) Engineer
Nel cuore della fisica non ci sono solo formule e teorie: ci sono scelte di vita, passaggi complessi e spesso anche lunghi viaggi. Fare ricerca oggi significa anche questo: inseguire la propria curiosità scientifica oltre i confini geografici, culturali e personali. Giovani ricercatori e ricercatrici si spostano da una città all’altra, da un Paese all’altro, mossi dalla passione per la conoscenza, ma spesso a caro prezzo.
Cambiare nazione per proseguire gli studi o lavorare in un laboratorio significa, per molti, ricominciare tutto da capo: nuove abitudini, nuovi ambienti, lontani da casa e dagli affetti. Non è una pratica straordinaria, anzi, è sempre più comune. Ma resta una sfida impegnativa, che richiede adattamento, sacrificio e molta determinazione.
Oggi ne parliamo con Marco Tagliaferri, giovane ricercatore e ingegnere cresciuto in mezzo alla scienza. Fin da bambino ha respirato l’aria dei laboratori e delle sperimentazioni, e oggi continua quel percorso come protagonista, tra studi internazionali, esperienze all’estero e nuove frontiere della fisica. Con lui esploreremo non solo il suo lavoro, ma anche il lato umano della ricerca: cosa significa davvero partire, cambiare, imparare a ricominciare.
- Ciao Marco, com'è nata la tua passione per la fisica e per la ricerca? Quale iter accademico e professionale hai intrapreso?
«Non c’è stato un momento preciso, è stato un percorso naturale direi probabilmente coltivato da mio nonno materno che era medico, ma appassionato di scienza. Mio padre è un astrofisico, sono cresciuto all’Osservatorio Astronomico di Brera, sede di Merate, e sin da piccolo vivevo in mezzo a scienziati. Guardare le stelle, intrufolarsi nelle visite guidate… la scienza per me era un gioco. A scuola mi piacevano fisica e matematica, e ho scelto il liceo scientifico quasi senza pensarci troppo.
All’università ho studiato Fisica alla Bicocca, e per la triennale ho scelto fisica della materia per trovare la mia strada differenziandomi da mio padre. Poi mi sono appassionato alla meccanica quantistica e ai dispositivi quantistici.
Dalla triennale alla magistrale e poi al dottorato, ho lavorato sempre in quel campo, tra Como e Agrate, soprattutto su tecnologie per il quantum computing. È stato un percorso lineare, più che una scelta improvvisa. Crescere in quell’ambiente, e con la libertà di perseguire ciò che mi piaceva, ha fatto la differenza.»
- Per approfondire la ricerca hai viaggiato molto. Ci puoi raccontare le tue esperienze nei vari luoghi?
«Durante il dottorato era caldamente consigliato trascorrere un periodo all’estero, per chi fa ricerca in Europa il passaggio all’estero è praticamente obbligatorio.
Inizialmente avrei voluto andare a Grenoble, ma poi un po’ per caso sono finito a Cambridge, nel laboratorio europeo di ricerca di Hitachi, proprio davanti al Cavendish Institute.
Facevano ricerca su dispositivi quantistici, in collaborazione col mio supervisore in Italia, ed erano parte di un progetto europeo. Lì ho potuto sviluppare competenze nuove, vincere un piccolo progetto indipendente e ampliare la rete di contatti. Alla fine del periodo, mi avevano anche proposto di restare, ma poi l’offerta non si è concretizzata.
Tornato in Italia, ho concluso il dottorato e dopo qualche mese come assegnista di ricerca nel gruppo del mio ex supervisore, ho avuto l’opportunità di entrare in un nuovo gruppo a Delft nei Paesi Bassi, presso il Qutech uno dei principali centri di ricerca nel campo del Quantum Computing, dove sono rimasto due anni. Terminata quell’esperienza, nonostante la possibilità di entrare al Niels Bohr Institute a Copenaghen, ho scelto di trasferirmi a Grenoble in Francia, dove ho trascorso un altro anno di ricerca nello stesso ambito presso il CEA. Dopodiché ho fatto una scelta abbastanza drastica accettando l’offerta di una multinazionale americana che produce dispositivi elettronici, decidendo di rientrare in Italia e abbandonando la ricerca accademica. Se da un lato questa scelta ha comportato il dover cambiare campo di ricerca, dall’altro mi ha permesso sia di continuare a fare ricerca industriale partecipando allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici che di esplorare nuovi orizzonti.»
- Lasciare la propria città o il proprio Paese per nuove opportunità è sempre una sfida. Quanto è stato difficile e che consigli sentiresti di dare a chi affronta lo stesso percorso, specialmente ai più giovani?
«Non è stato troppo difficile per me, forse perché ero già abituato al cambiamento: sono nato nei Paesi Bassi e mi sono trasferito in Italia da piccolo. Uscire dalla comfort zone tutto sommato mi è sempre piaciuto. La fase iniziale di adattamento, rifarsi una rete, imparare come funziona la quotidianità, l’ho vissuta con curiosità.
È normale, quando si arriva in un posto nuovo, sentirsi soli all’inizio. È una fase che fa parte del percorso. Non c’è una ricetta per uscirne: sta molto alle persone, alla loro voglia di mettersi in gioco. Personalmente, non ho mai seguito uno schema preciso, neanche nelle tre esperienze che ho fatto all’estero. Però una cosa che conta davvero è costruirsi una propria routine: avere dei piccoli punti fermi ogni giorno aiuta tanto a sentirsi a casa.»
- Quali sono le differenze per quanto riguarda il ruolo e la considerazione dei ricercatori in Italia e all’estero?
«Le differenze sono sia economiche che culturali. In Italia, il dottorato può essere finanziato dallo Stato o dai progetti del professore, e spesso, come nel mio caso, si percepisce uno stipendio molto basso. Questo riflette una visione del dottorando come studente più che come lavoratore. All’estero, invece, il dottorato è considerato un vero e proprio lavoro, con stipendi più vicini a quelli di uno junior engineer e con una struttura più chiara e valorizzata.
In Italia inoltre mancava, e spesso manca ancora, una prospettiva definita dopo il dottorato: non è raro che chi resta troppo a lungo nella ricerca accademica fatichi poi a trovare spazio nell’industria. Questo crea un’incertezza che scoraggia molti giovani talenti.
Anche la percezione sociale è diversa. All’estero dire che fai il ricercatore o lo scienziato implica prestigio e riconoscimento. In Italia suscita curiosità, ma manca una comprensione diffusa di cosa significhi davvero fare ricerca, e questo si riflette anche nel poco investimento pubblico e privato nel settore.»
- Quali sono gli aspetti più gratificanti e quelli più difficili della ricerca?
«La gratificazione più grande è vedere un risultato concreto, sapere che è frutto del tuo lavoro e, ancora di più, contribuire alla crescita delle persone nel tuo team. È un orgoglio che va oltre il singolo progetto: è il senso di fare qualcosa che lascia un segno, anche piccolo, nella comunità scientifica e nelle persone.
La parte più difficile è che, nonostante l’impegno, i risultati non sempre arrivano. E in ricerca questo pesa: rinnovi, borse di studio, avanzamenti di carriera dipendono spesso da metriche rigide. C’è una forte pressione a pubblicare, talvolta a scapito della qualità. Questo sistema rischia di spingere anche i ricercatori più seri a forzare i tempi o le conclusioni, alimentando la pubblicazione di studi poco accurati. Sarebbe importante ridare valore alla ricerca solida, anche se più lenta.»
- Cosa ti ha insegnato la ricerca, al di là della scienza?
«Sicuramente il mondo della ricerca accademica può essere molto focalizzante ed essere percepito come una attività diversa dal lavoro “vero”. Però non sono da sottovalutare le innumerevoli soft skills che il fare ricerca richiede di sviluppare e che permettono, come nel mio caso, di poter fare scelte abbastanza radicali. Innanzitutto, nel mondo della ricerca è abbastanza normale dover lavorare con persone di culture e nazionalità diverse, spesso in team multidisciplinari. Inoltre, come detto prima, saper fare networking fa parte del fare ricerca, come il saper affrontare e risolvere problemi ed imprevisti, oltre a contribuire alla crescita di nuove generazioni di studenti. Inoltre, dover presentare i propri risultati in modo chiaro ed efficace permette di perfezionare la comunicazione. Da ultimo il senso critico, il voler capire le cose e non accontentarsi di spiegazioni facili.
Tutte queste conoscenze, unite alla curiosità, permettono ad un ricercatore di reinventarsi e possono facilitare il passaggio dal mondo della ricerca accademica a quello extra-accademico ed imprenditoriale (come dimostrano le innumerevoli nuove startup nel mondo delle tecnologie). Potremmo dire che la ricerca insegna ad imparare.»
- Che consigli ti sentiresti di dare a una nuova generazione che si vuole affacciare al mondo della fisica e della ricerca?
«Chi sceglie la fisica lo fa per passione: è quella il vero motore. Se c’è passione, vale la pena buttarsi nella ricerca. Bisogna però sapere che, in ogni caso, qualcosa si sacrifica. Se si va all’estero per crescere, per appagamento scientifico, personale o anche economico, spesso si rinuncia ai rapporti quotidiani con la famiglia e agli affetti. È un compromesso: da una parte vinci, dall’altra perdi.
Certo, dipende dalle persone: c’è chi riesce a mantenere forti legami e sente meno il distacco. Ma in ogni caso andare all’estero è utile, se non fondamentale, per allargare il proprio network nella comunità scientifica e anche per allargare la propria mente grazie all’incontro con altre culture e modi di pensare o agire.
Chi invece sceglie di restare in Italia oggi trova condizioni migliori rispetto al passato: con il pensionamento della generazione dei baby boomers, si stanno aprendo nuove possibilità anche nelle università.»
Nicola Magni
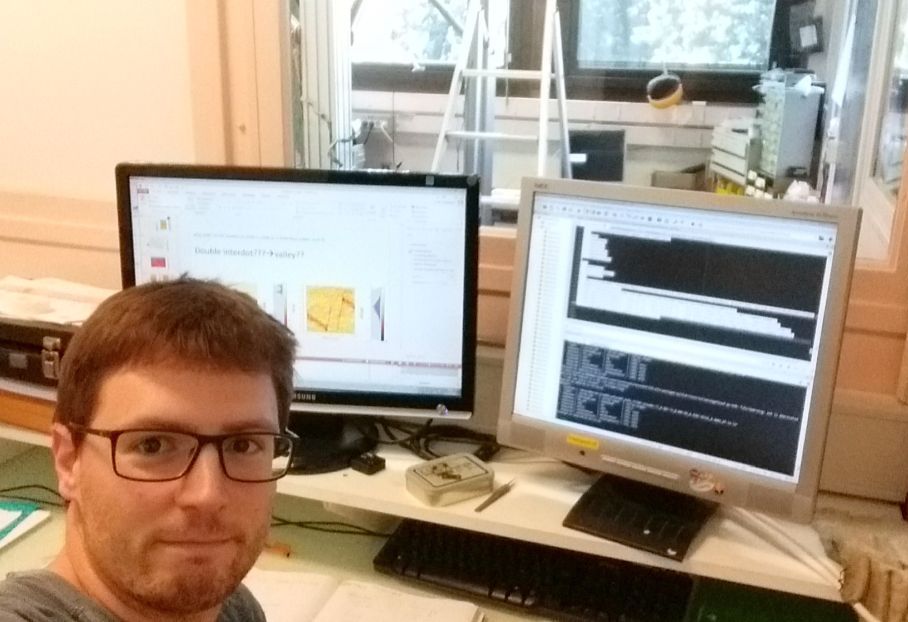
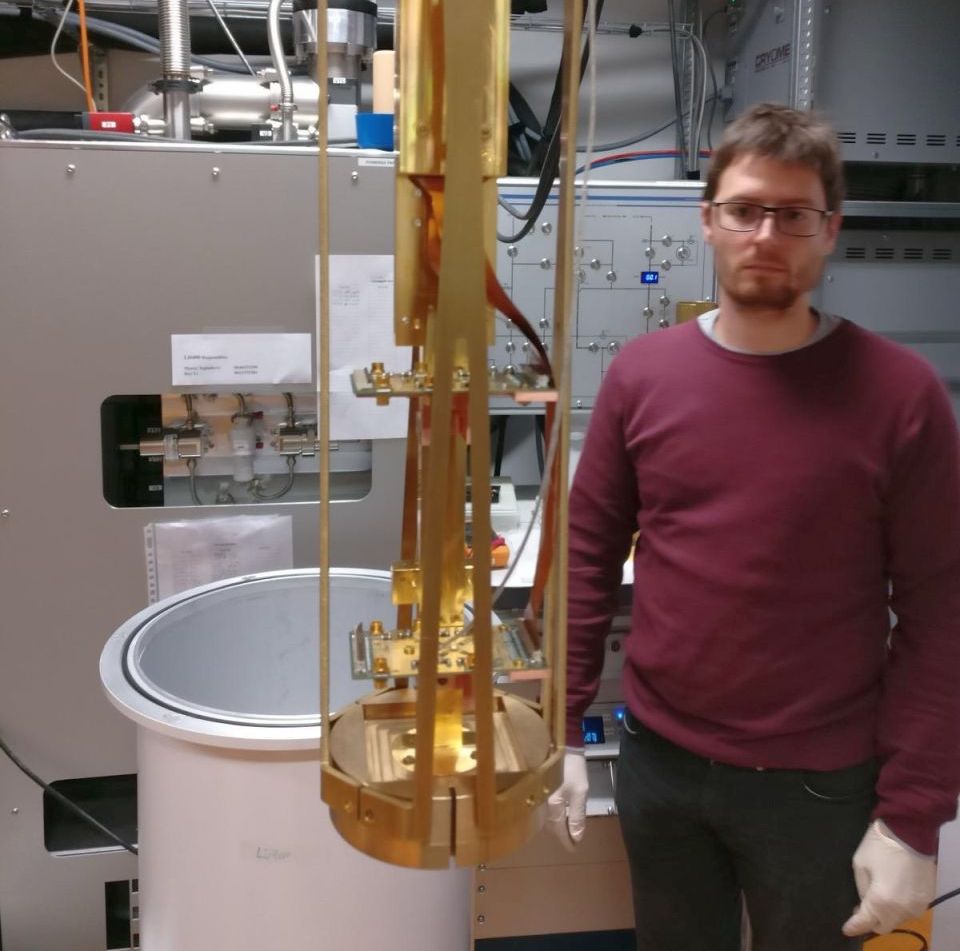
La Gazzetta ha bisogno di te.
Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.

Il consolato del mese
CONSOLATO ONORARIO DI SVIZZERA A BERGAMO
Sede: Bergamo
Console Onorario: avv. Daniel Vonrufs
Zona di competenza: Bergamo e Provincia
Mansionario: mantenere i contatti con le autorità locali, la promozione dell’immagine della Svizzera in relazione ai suoi interessi economici e commerciali, mantenere contatti stretti con la comunità svizzera locale, assistere i cittadini svizzeri anche di passaggio nella circoscrizione di Bergamo, informativa regolare al Consolato generale su accadimenti di interesse della Confederazione nella circoscrizione di Bergamo.
Telefono: +39 035 212915
Mail: bergamo@honrep.ch
«Bergamo e la Svizzera si assomigliano per serietà, operosità e sobrietà. Lavoro per custodire e rafforzare il legame con la tradizione elvetica, radicata nei profondi rapporti culturali ed economici che uniscono da tempo queste due realtà.»